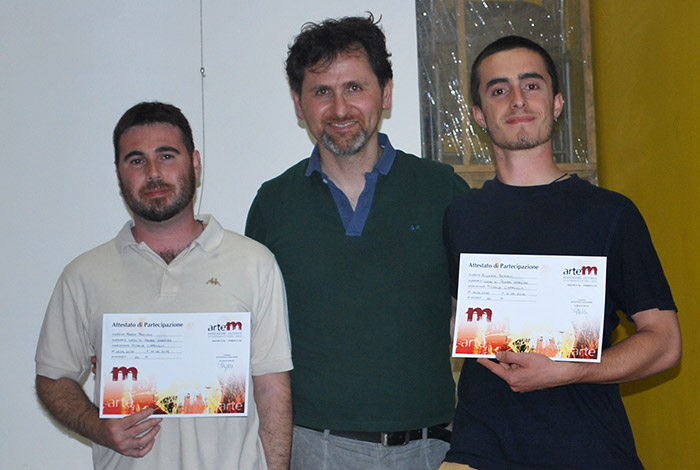Chiavi in mano, aveva consegnato tre mensilità anticipate e due mesi di caparra a quel tizio con la erre moscia, che diceva di chiamarsi Gabviele.
Soltanto una settimana dopo Niceta aveva saputo che Gabviele si faceva chiamare Bijou da coloro che volevano divertirsi e sniffare un po’ di coca al parco dei transessuali. Glielo aveva riferito una sera, davanti a un paio di bottiglie vuote di Sparviere, Aristotele Marinoni detto Verso Libero, il padrone del “Punto e virgola”, la trattoria dove da un po’ di tempo Niceta aveva preso l’abitudine di consumare i pasti:
«Bijou è uno che con il culo ci sa fare... Bijou è uno che con il culo e la coca s’è comprato mezza Milano... Quel demonio attende i suoi polli sotto la chioma di un salice piangente e poi li spenna in un attico scintillante di tette al silicone e di falli superaccessoriati. Li tiene in pugno con il culo e la coca i suoi polli. Circondati da aggeggi multiuso che vibrano all’unisono, folgorati da timballi e profumi d’ogni genere, tra ambrosiane rapsodie che salgono dai testicoli, pollastri insospettabili si accendono di voglie inenarrabili in quell’attico di quattrocento metri quadri.»
E un minuto dopo, ricordandosi forse d’essere non solo un incompreso poeta milanés, ma prima di tutto un meneghin che dalla mattina alla sera si fa el cu nella sua trattoria, aveva aggiunto:
«L’ha mai laurà, Bijou!»
Sulle prime Niceta c’era rimasto di sale. Questa cosa del culo alla coca venduto a pochi metri di distanza da casa sua non gli andava proprio giù. Certi individui lui non li aveva mai potuti digerire, non gli erano mai andati a genio. Non che li odiasse, ci mancherebbe altro, ma li avrebbe presi volentieri a calci nel sedere. A Larino certe cose non si vendevano da nessuna parte, di questo ne era assolutamente certo, e se qualcuno avesse acquistato culo e coca al mercato nero nessuno lo avrebbe mai saputo.
Avrebbe voluto andarsene al più presto da quel bilocale, ma avrebbe perso la caparra se avesse cambiato casa senza i sessanta giorni di preavviso.
Niceta viveva in quel bilocale da un paio di mesi, esattamente dal giorno in cui Pietro Campanacci, il maresciallo di Larino, gli aveva riferito che lo smartphone di Federico era stato localizzato a Milano, tra corso Genova e via Conca del Naviglio, tra via Cicco Simonetta e via Scaldasole, prima di diventare per sempre muto.
Gli era rimasto solo Federico. Ma una notte Federico se n’era andato via, lasciandogli queste poche righe:
“Babbo, me ne vado. Non mi cercare. Dove andrò non lo so ancora. Solo Dio sa dove sarò domani. In qualche modo me la caverò. Ti vorrò sempre bene. Federico.”
Sua moglie Assunta se ne era andata dopo una breve malattia solo due settimane prima. Lui e Federico, da quando le avevano diagnosticato un cancro alla mammella, avevano avuto occhi solo per lei, traboccante di travagli e di morfina.
Una sera cupa e triste, al cospetto di una luna clandestina, Federico, con le lacrime agli occhi, aveva confidato al padre che lì dove era nato e cresciuto non aveva un avvenire, non aveva prospettive, che aveva bisogno di ritrovare se stesso lontano da Larino. Dove ancora non lo sapeva, no, non lo sapeva ancora. Inoltre, da un po’ di tempo si sentiva molto giù: non aveva più la mamma, non aveva un lavoro, non l’aveva neppure cercato, non aveva la ragazza, non aveva inclinazioni particolari.
Forse c’era dell’altro, doveva esserci dell’altro, non poteva non esserci dell’altro, si diceva spesso Niceta, scacciando brutti pensieri. Una delusione amorosa, un’amicizia finita male, la domanda per diventare carabiniere persa in qualche stanzone al Ministero della Difesa, o forse tutte queste cose messe insieme. Cose che capitano a tutti i ragazzi prima o poi. Quando non si hanno ancora vent’anni non sono infrequenti le crisi d’identità.
In un primo momento, perciò, non aveva dato molta importanza a quella rivelazione. Qualche giorno dopo, però, scoprendosi sempre più turbato, preoccupato e tormentato, aveva preso la decisione di affrontare di nuovo l’argomento con Federico. Aspettava il momento giusto per farlo. Aspettava una sera luminosa e chiara, una luna immensa e dolce.
Ora anche Federico se n’era andato. Da qualche parte o forse da nessuna parte. Con un treno o sotto un treno. Con un camionista di passaggio o sotto il viadotto di un’autostrada, con un’imbarcazione a vela verso lidi sconosciuti o in fondo all’oceano, nudo, la chioma gelida, la carne lacerata dagli squali.
Federico aveva preso con sé solo poche cose. A casa, sul comodino, accanto al biglietto per il padre, aveva lasciato la patente e la tessera della biblioteca comunale. Ma non si era dimenticato della madre prima di scomparire nel nulla. No, non se n’era dimenticato. Sotto la sua croce aveva piantato la più bella violetta del pensiero di Larino.
“Babbo, me ne vado. Non mi cercare.”
Ma come si fa a non cercarlo, un figlio? Un figlio con la testa sulle spalle, buono e premuroso come Federico? Un figlio innamorato della vita e attaccatissimo alla sua terra? Come si fa a non cercarlo, un figlio così?
Tutti in paese, compresi i cani randagi e le talpe mezzo assonnate, le farfalle notturne e le cicale stonate, avrebbero dato la loro vita pur di ritrovare vivo e in buone condizioni quell’acerbo frutto molisano e riconsegnarlo all’amore di Niceta.
L’avevano cercato dappertutto. A Larino e nella campagna attorno. Tra i declivi verdeggianti e le spighe odorose, sulle colline straripanti di ulivi, tra i monumenti funerari in rovina dell’antica Larinum e nell’acqua incantata e scintillante del Biferno.
Nulla. Nulla da fare. E tutte le sere l’ennesima condanna a morte pronunciata a voce bassa dal maresciallo dei carabinieri di Larino:
«Federico non si trova, per ora non si trova, ma non disperi, signor Niceta, tutte le forze dell’ordine del Paese sono state allertate. Prima o poi qualcosa ne uscirà fuori, signor Niceta.»
E quando il telefono di casa la notte si metteva a squillare, Niceta tratteneva a lungo il respiro prima di sollevare la cornetta. Pregava e tremava. Ma erano soltanto sciacalli.
Un mattino il maresciallo lo aveva mandato a chiamare. Doveva comunicargli una notizia importante.
Quando aveva varcato il portone della caserma, Pietro Campanacci gli aveva messo una mano sulla spalla, dicendogli che avrebbe dovuto reggersi forte: alle ventidue e quarantasette del ventiquattro maggio il telefonino di Federico aveva agganciato la cella telefonica quarantadue di Milano! Non era questa una bella notizia? La telefonata che Federico aveva fatto, una telefonata in uscita durata pochi secondi, era qualcosa da cui poter ripartire, qualcosa su cui puntare forte. I carabinieri di Milano si stavano già dando da fare con i cani molecolari fatti venire appositamente dalla capitale per rintracciare Federico.
Niceta non ci aveva pensato due volte. Era partito immediatamente per Milano con il primo regionale veloce. Seicentonovantanove chilometri. Seicentonovantanove chilometri di speranza. Senza mai chiudere un occhio o arricciare il naso. Con una bottiglia da mezzo litro di Grottino di Roccanova, la valigia di cartone di quando era andato in viaggio di nozze, la fotografia in bianco e nero di Assunta, ma soprattutto con un obiettivo ben preciso stampato sul cuore: ritrovare Federico a ogni costo, scandagliando le piazze, i viali, i vicoli, le panchine, i ricettacoli di Milano.
Sopravvivere alla morte di un figlio è morire ogni giorno. Nulla sarà mai più uguale a prima.
Sopravvivere a un figlio che scompare nel nulla è forse peggio di un’esistenza orfana di un figlio. I giorni sono tutti maledettamente uguali, i momenti felici echi lontani, le speranze senza illusioni, le illusioni croci conficcate nella carne. E il vuoto dentro ti segue ovunque, sempre. E poi quel grido lacerante e disumano rivolto al mondo intero:
«Dov’è mio figlio? Sta soffrendo mio figlio? Che ne è del suo cadavere?»
Niceta non aveva più voce per quel grido, ma aveva una cella telefonica.
«Sì, va bene, affare fatto, lo prendo» aveva detto alla fine a quell’irremovibile giovanotto che lo guardava dall’alto al basso, tirando fuori da un taschino della giacca un mucchietto di banconote di grosso taglio tenute insieme con un elastico.
E dal giorno dopo aveva incominciato le ricerche in quella cella.
Cella quarantadue. Dentro quella cella, da qualche parte, doveva esserci ancora Federico; forse aveva per sempre piantato le tende lì, al quarantadue; forse al quarantadue aveva finalmente ritrovato se stesso; forse, chi lo sa, era ospite di un bijou o di una tusa che aveva conosciuto su feisbuk o su una ciat prima di andarsene. Che ne sapeva lui di certe diavolerie! Lui apparteneva alla generazione di coloro che, allargando le braccia, urlavano al vento:
«Si stava meglio quando si stava peggio!»
A Milano il sole di luglio spaccava le guglie, i lampioni, le insegne dei negozi, faceva calare la pressione alla Madonnina, perdere la testa a San Vittore, collassare Sant’Ambrogio. Si attaccava alle scarpe, che diventavano subito appiccicose e bisognava poi buttare via. Ci si stancava subito sui marciapiedi di Milano. Niceta li batteva a palmo a palmo sbirciando nei contenitori della spazzatura e nelle casette di cartone dei senzatetto, annusando le bottiglie di birra vuote abbandonate fuori dei pub, spalancando gli occhi nelle stazioni del metrò, arrampicandosi sui monumenti e sulle guglie delle chiese alla ricerca di un indizio, un suono familiare, un odore, quell’odore, di una faccia, quella faccia.
Trasferiva le fotografie a colori di Federico dalle sue tasche ai murales, ai cartelloni pubblicitari, ai pali dei lampioni, alle colonnine di cemento ai lati delle vie. Le distribuiva agli interisti e ai milanisti, ai pentastellati e ai forzisti. A Larino, prima di partire per Milano, ne aveva fatte stampare centinaia di fotografie di suo figlio. In basso, sulla destra, aveva fatto riportare i suoi tratti somatici: l’età, il peso, il colore degli occhi, quello dei capelli, la voglia color salmone sotto l’ascella sinistra, l’accento molisano. E, aggiunto a penna, il suo nuovo indirizzo di Milano e il numero di telefono della stazione dei carabinieri di Larino.
Anche Aristotele Marinoni, di domenica, il giorno di chiusura del “Punto e virgola”, aveva cercato Federico in lungo e in largo.
Tutto era stato inutile. Al quarantadue di Federico non c’era traccia. Ma la speranza, così si dice quando non si ha nient’altro da dire, è sempre l’ultima a morire. Per un padre disperato, basta e avanza.
A tutti aveva continuato a chiedere notizie. Persino a se stesso, lo aveva chiesto quando gli era capitato di osservarsi attraverso le vetrine dei negozi. Tirava fuori da una scatola di cartone la fotografia di Federico e con voce accorata domandava:
«Non ha visto mica lei questo ragazzo...»
Alle quattro del pomeriggio di un sabato di fine estate, mentre ascoltava alla radio un programma sulla crisi che di recente aveva colpito i cinema a luci rosse, a Niceta venne in mente il parco dei transessuali. Fin là, di notte, non aveva mai osato spingersi. Di giorno, seppur a testa bassa, quando era sicuro che nessuno lo avrebbe visto, aveva attraversato più di una volta quel luogo di perdizione ma, quando la notte stava per calare, il pudore e la paura di essere riconosciuto dai vicini di casa o dai clienti del “Punto e virgola”, gli avevano fatto cambiare strada. Eppure, da quello che Verso Libero una volta gli aveva riferito, dalle undici di sera alle quattro del mattino del giorno dopo Il bazar del culo e della coca di via Conca del Naviglio veniva preso d’assalto da uomini provenienti da ogni luogo alla disperata ricerca di una propria identità.
Niceta si avvia carico di speranza al parco dei transessuali.
Sebbene siano solo le dieci, dieci e mezza circa, c’è già un discreto movimento sotto i salici piangenti. Ma da dove si trova ora è quasi impossibile mettere a fuoco i contorni delle ombre. Niceta dovrebbe avanzare di qualche metro per poter dare un nome preciso alle cose.
Curvo come un arco, lo sguardo fisso davanti a sé, Niceta avanza lentamente tra i salici e un momento dopo, arrossendo di vergogna, si nasconde dietro un cespuglio. Si sente addosso mille occhi, mille occhi verdi, rosa e viola che lo scrutano e lo studiano, che forse lo stanno giudicando o deridendo.
Si fa coraggio. Alza la testa. Si guarda attorno. Si stropiccia gli occhi. Li strizza più volte. Ciò che vede lo lascia a bocca aperta: un variopinto campionario di femmine stupende dal look mozzafiato! Sfingi di seta con lunghe calze a rete, labbra straripanti di rossetto, steli voluttuosi, fari carnosi, audaci cadenze delle anche, guizzi iridescenti d’impossibili tacchi a spillo!
Scosso da quei precipizi di piacere, muove altri passi in quella direzione. Lentamente, molto lentamente li muove.
Un’ombra color pesca dice:
«Nonnino, sei fuggito dall’ospizio? Sei venuto qui per spassartela un po’, nonnino? Ce l’hai l’assicurazione sulla vita, nonnino bello?»
Due occhi verde acqua, illuminati appena dalla fioca luce di un lampione, lo guardano con aria divertita.
Niceta non ci fa caso. Non sente e non vede nulla. Solo il canto del suo cuore sente.
L’ha riconosciuto mentre scendeva dalla macchina di un tizio con gli occhiali scuri, che è subito ripartita. Dall’odore l’ha riconosciuto. Quell’odore non c’era un paio di minuti prima.
Quell’odore ora si sta guardando in uno specchietto, si sta passando sulle labbra un po’ di rossetto, si sta applicando con un pennellino qualcosa sulla faccia, sulle palpebre e sugli zigomi sporgenti.
Niceta non grida. Vorrebbe farlo, ma si tappa la bocca con la mano, ricacciando in gola le parole che gli salgono dal cuore. Rimane in quella insolita posizione un minuto o due per non disturbare la bellezza di quel momento. Non sa spiegarsi perché non corre a buttargli le braccia al collo, ora che l’ha finalmente ritrovato, il suo Federico. Arretra silenziosamente di qualche metro. Si rimpicciolisce dietro un salice sorridente.
«Nonnino, che fai lì acquattato? Non ti vergogni mica, nonnino?» gli domanda un bijou. «Nonnino, non ti nascondere, non fare il timido, li hai cinquanta euro, nonnino bello? Sarò completamente tua per cinquanta euro!»
Niceta fa per dire qualcosa, ma poi non dice niente. Strappa una fogliolina color verde molisano da un ramoscello che gli solletica la punta del naso e un istante dopo la depone con delicatezza nel taschino della camicia. Infine, agitando la mano, saluta il parco dei miracoli e si allontana.
Sul treno che lo riporta a Larino, l’amore per suo figlio ricomincia a crescere a dismisura. Non cesserà mai di crescere.
Federico è vivo, il resto è poca cosa.